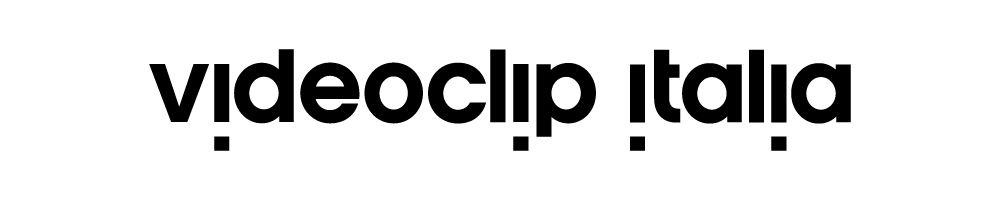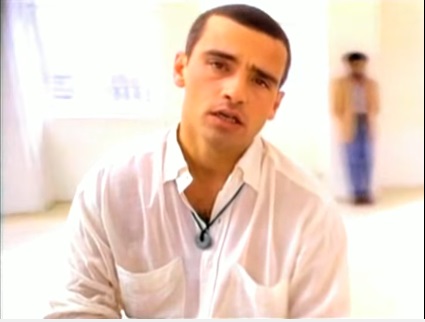Fotoromanzi – Il classico senza classicismo, una rubrica di Alberto Beltrame
Sono davvero tanti i motivi per i quali Atlanta (di cui l’autore e protagonista è un volto noto anche nell’ambito del videoclip) è una delle serie tv più importanti degli ultimi anni: una struttura narrativa totalmente anarchica, il ritorno preponderante del dialogo e delle relazioni tra individui al di là della gerarchia strutturale, un approccio decisamente politico all’idea di comunicazione e società dei consumi. Ma soprattutto una descrizione eccezionalmente originale della comunità afroamericana negli Stati Uniti.
La retorica del vittimismo è presa a calci nel culo per lasciar spazio a una sorta di legge della sopravvivenza nel mondo della globalizzazione. Proprio dove tutto si fonde, s’influenza e si mescola senza lasciar traccia, si svela l’origine, la differenza storica, le conseguenze che si vorrebbe far finta di non vedere nel nome del progresso. Dove tutto sembra essere passato, risorge la rabbia di Malcom X tagliata attraverso la cocaina dei quartieri alti: non si può nascondere e non si può comprare un dolore forgiato nell’ingiustizia. E così, più che una divisione in noi “gli afroamericani” e loro “i bianchi”, si stabilisce una frontiera di comprensione e consapevolezza che non si può superare. Un limite, una sorta di barriera che proprio nell’atto artistico sembra affermarsi con maggior forza.
Il solo pensiero di dover ricordare tutto questo al regista afroamericano più importante della Storia ci sembra davvero stupido. Eppure Spike Lee nel 1993 fa un’operazione assai particolare. Invita un ragazzo bianco nella sua New York e lo filma in mezzo a una comunità di afroamericani per farne il promo di una sua canzone. Eros Ramazzotti nel bel mezzo di una cultura che non è la sua, la decontestualizzazione più riuscita possibile per il regista più politico del panorama cinematografico americano.
Perché Spike Lee abbia accettato un lavoro del genere, per il quale ci mette pure la faccia (infatti compare all’interno del video stesso interpretando un fotografo), rimane un mistero. Sicuramente una questione di soldi, ovvio, ma probabilmente avrà visto qualcosa in Ramazzotti che lo aveva particolarmente colpito. Di certo abbandona per un attimo ogni ragione politica e sociale.
Forse c’era molta euforia nell’aria, che lo faceva essere meno militante e pensare un po’ di più a divertirsi. Perché quell’autunno del 1993 per Spike Lee non era un autunno qualsiasi. Qualche mese prima si era ritirato per la prima volta Michael Jordan, che per un tifoso sfegatato dei New York Knicks voleva dire che c’era finalmente spazio nella Conference Est per poter andare in finale a giocarsi il titolo.
E infatti fu così: senza quell’ingombrante perfezione che erano i Chicago Bulls vincitori delle ultime tre edizioni della NBA, New York riusciva nella primavera del 1994 a raggiungere prima le finali di Conference, dove Reggie Miller osò sfidare il nostro Spike Lee con la miglior partita della vita proprio a casa sua al Madison Square Garden, e poi le Finals. Non finì in gloria perché Houston si impose con un beffardo 4-3 che lasciava davvero tanto amaro in bocca. Anche perché poi, tranne l’altra finale del 1999 (anch’essa nell’anno successivo a un ritiro di Jordan, il secondo dei tre) persa contro le altre “Torri Gemelle” (ovvero quelle di San Antonio), per la squadra di Spike Lee seguiranno anni davvero amari con ben poche soddisfazioni.
In ogni caso sembra che Ramazzotti abbia preso gusto a questa fusione culturale con la comunità afro. Infatti a distanza di qualche anno incide un’altra versione della canzone per un duetto con una cantante afroamericana. Questa versione in coppia con Tina Turner, e il video di conseguenza, sapranno avere ancora più successo rispetto all’originale del 1993 (per i feticisti poi c’è pure il video leggermente modificato per la versione in spagnolo della canzone).
Anche questa volta il regista è un nome noto, ovvero quel Nigel Dick celebre per aver diretto tra i più celebri videoclip di Britney Spears, The Offspring, Cher, Oasis e tanti altri. Un regista che aveva già lavorato con lo stesso Ramazzotti l’anno precedente per il videoclip di Più bella cosa, dove aveva dato il meglio di sé per creare una possibile tensione narrativa a un Ramazzotti che in mezzo al deserto gioca a nascondino con Michelle Hunziker.
Se Eros Ramazzotti è il cantante italiano più conosciuto al mondo qualche motivo ci sarà. Il talento nel sapersi vendere in mercati così diversi a quello del nostro Paese è un dato di fatto. Essere riuscito a convincere un regista dello spessore di Spike Lee a lavorare con lui è qualcosa di davvero sbalorditivo per i motivi già analizzati.
L’incognita rimane sempre sulla figura del regista afroamericano, che proprio all’inizio degli anni Novanta era probabilmente nel suo periodo artistico più importante. E politicamente parlando non si può non ricordare che i due film che precedono questo videoclip, ovvero Jungle Fever e Malcom X, rappresentano i prodotti forse più radicali sulla questione afroamericana del suo cinema. Eppure quell’autunno era speciale: c’era bisogno di una canzonetta melodica all’italiana per accompagnare quelle notti magiche inseguendo il sogno di un titolo NBA che mancava (e manca tutt’ora) dal lontano 1973.